“La Dominante dei mari”. Questa era Genova al tempo glorioso delle Repubbliche marinare, nel periodo basso medievale e rinascimentale. Riconosciuta a livello internazionale come potenza economica e commerciale, ed ammirata per le ottime capacità in battaglia, può dire di aver conservato un po’ di quello spirito anche nei secoli successivi.
Un esempio? Gli anni Sessanta. Forse davvero il decennio più intenso, più vivo nella storia moderna della città. Punto di riferimento del triangolo industriale con Torino e Milano e con un passato decisivo nella Resistenza, Genova è stata anticipatrice anche dei movimenti operai e studenteschi del ‘68, insieme a Torino, dove le prime manifestazioni di lavoratori si ebbero già verso il ’65. Non solo. Ancor prima, un episodio di ribellione e libertà segnò una delle pagine più critiche nella storia della Prima Repubblica. Siamo nel 1960, l’Italia abbraccia il boom economico, dopo anni di sudore e sacrifici. E’ in questo contesto storico e sociale, ancora lontano dalle rivolte degli anni successivi, che Genova si ribella, fiera del suo passato antifascista. Così, il trenta giugno, la gente scende in piazza. Il motivo? Un Congresso dell’ “M.S.I.” programmato da tempo in città. Inaccettabile per i genovesi. Il Congresso però, è legittimato dalla situazione politica del momento: il nuovo governo Tambroni, per essere eletto, ”chiede” ed ottiene l’appoggio dei missini, che risulta determinante e che ufficialmente “reintegra” i neofascisti da quell’emarginazione in cui erano stati relegati dopo la fine della guerra. I missini cavalcano l’onda e prima tengono un Congresso a Milano, poi ne pianificano un altro a Genova, proprio nella città cuore della Resistenza. La gente si ribella, mai avrebbe accettato un’onta simile. Si susseguono giornate di scontri tra manifestanti, carabinieri e neofascisti. A fine luglio il Governo Tambroni si dimette.
Passano pochi anni e Genova, insieme a Torino, apre le “danze” delle proteste operaie e studentesche, che hanno il loro picco nel ’68 e che prenderanno pieghe drammatiche negli anni Settanta, ricordati non a caso come gli anni “di piombo”.
Non è, ovviamente, soltanto protesta e battaglia la storia di Genova. E’ anche amore, poesia, dolcezza. Forse malinconia. Ecco, una dolce malinconia. Quella che ci hanno lasciato nel cuore gli splendidi cantautori genovesi nelle loro canzoni. La scuola genovese, che fiorisce proprio negli anni ’60, ci parla di vita, di libertà e di amore. Il tutto con un meraviglioso romanticismo malinconico. I nomi? Bindi, Lauzi, De Andrè, Tenco, Paoli. Non c’è bisogno d’aggiungere altro.
Interpreti di un’Italia libera e risorta dalle macerie morali del passato. Cantano di un Paese tenero e battagliero, dolce e coraggioso. Termini per molti in antitesi. Non per loro. Non per Genova, città di lotte dure per la libertà. Già, la libertà. Un mondo sconfinato dove parlare di noi, della piccola vita di tutti i giorni, piena di tutto quello che la vita è.
“La canzone dell’amor perduto”, del mai dimenticato De Andrè e citata nel titolo, racconta proprio questo: la fine malinconica di un grande amore. Che, però, porta subito a ricominciare, a lottare. Quindi di nuovo ad amare. E’ “Zena” ragazzi. Ecco forse perché, come cantava Bruno Lauzi, “abbiamo un’espressione un po’ così…mentre guardiamo Genova”.





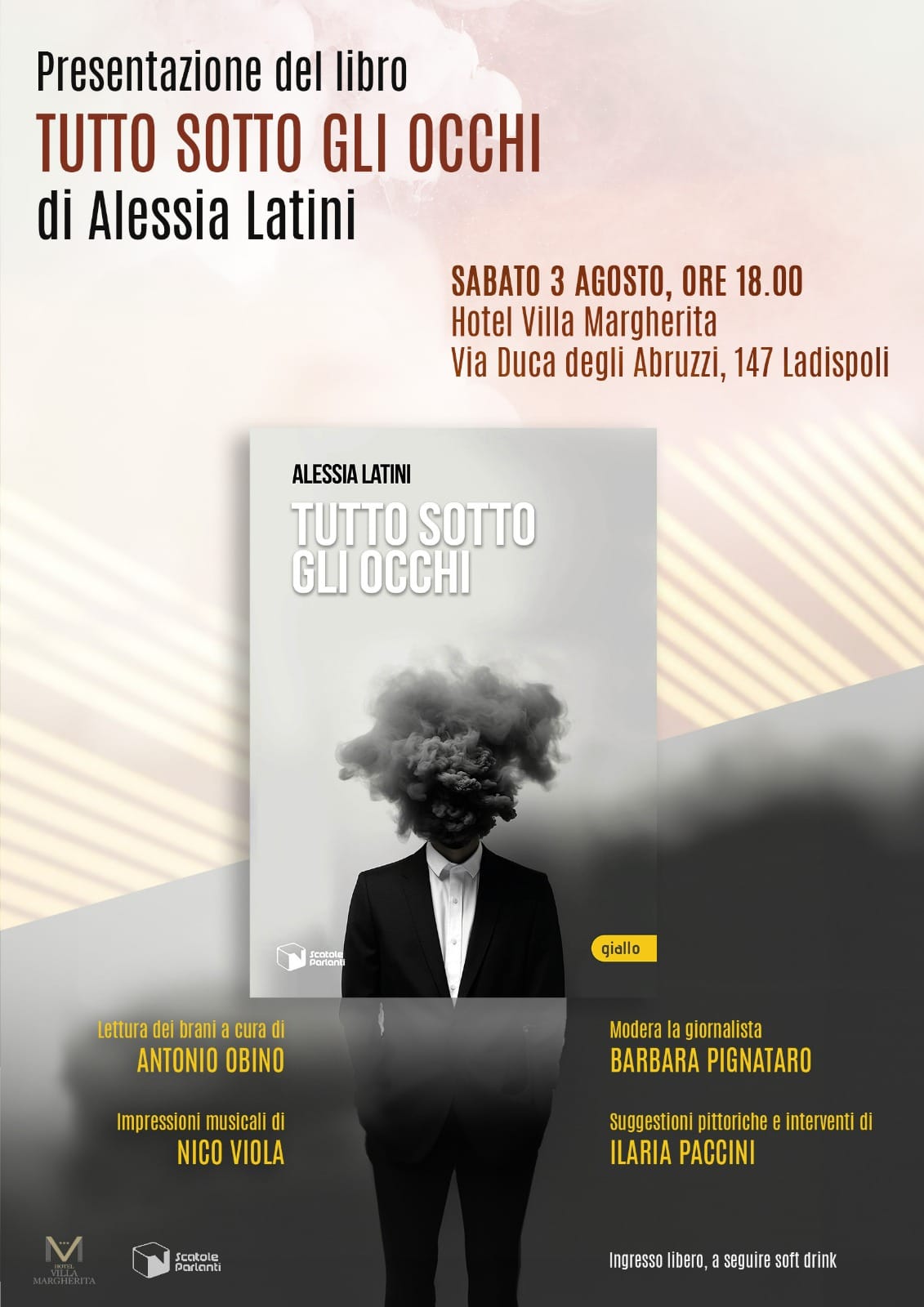



.jpg)








